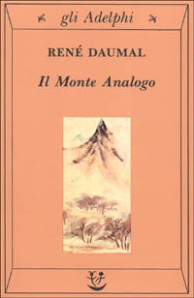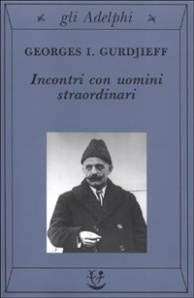 Georges Ivanovič Gurdjieff (1872-1949) filosofo, santone, mistico, scrittore, maestro di vita, viaggiatore, protagonista di avventure rocambolesche e fuori dall’ordinario, ha avuto un grande numero di discepoli durante la sua vita e ancora oggi i suoi seguaci sono distribuiti in tutto il mondo. Arrivato in Francia nel 1922 fonda l’Istituto per lo Sviluppo Armonico dell’Uomo al castello del Prieuré, presso Fontainebleau. Qui i suoi discepoli si riunirono in una comunità indipendente, il cui scopo principale era quello di compiere un’approfondita conoscenza di sé applicando il metodo del maestro, attraverso tecniche ed esercizi ben precisi. Dopo un grave incidente automobilistico avuto nel 1924 Gurdjieff inizia la sua attività di scrittore per tramandare la sua dottrina anche dopo la morte.
Georges Ivanovič Gurdjieff (1872-1949) filosofo, santone, mistico, scrittore, maestro di vita, viaggiatore, protagonista di avventure rocambolesche e fuori dall’ordinario, ha avuto un grande numero di discepoli durante la sua vita e ancora oggi i suoi seguaci sono distribuiti in tutto il mondo. Arrivato in Francia nel 1922 fonda l’Istituto per lo Sviluppo Armonico dell’Uomo al castello del Prieuré, presso Fontainebleau. Qui i suoi discepoli si riunirono in una comunità indipendente, il cui scopo principale era quello di compiere un’approfondita conoscenza di sé applicando il metodo del maestro, attraverso tecniche ed esercizi ben precisi. Dopo un grave incidente automobilistico avuto nel 1924 Gurdjieff inizia la sua attività di scrittore per tramandare la sua dottrina anche dopo la morte.
Dal mio punto di vista, può venire chiamato straordinario soltanto l’uomo che si distingua da quelli che lo circondano per le risorse del suo spirito e che sappia contenere le manifestazioni provenienti dalla propria natura, pur mostrandosi giusto e indulgente verso le debolezze altrui.
Incontri con uomini straordinari, pubblicato nel 1960 e del quale esiste anche una trasposizione cinematografica realizzata nel 1978 da Peter Brook, suo discepolo, racconta in forma autobiografica dei pellegrinaggi durati circa vent’anni (dal 1887 al 1907) in giro per il mondo insieme ai Cercatori della verità e le storie legate alla conoscenza di uomini determinanti per il suo percorso di crescita interiore, che, volontariamente o involontariamente, hanno agito da fattore vivificante per la formazione definitiva di uno degli aspetti della mia attuale individualità.
Mi propongo di dare all’insieme delle idee che sto per esporre una forma accessibile a tutti, nella speranza che queste idee potranno servire da elementi costruttivi e preparare il cosciente dei miei simili a edificare un mondo nuovo – mondo reale secondo me, e suscettibile di essere percepito come tale da ogni pensiero umano senza il minimo impulso di dubbio – al posto di questo mondo illusorio che i nostri contemporanei si rappresentano.
In effetti Gurdjieff riesce nel suo proposito, l’esposizione è chiara ed accessibile in tutto il libro. Il suo intento principale consiste nel tentativo di risvegliare le coscienze, unico modo per potere cambiare il mondo, modificandone radicalmente la percezione che abbiamo di esso. Gurdjieff parla di risveglio poiché è convinto che attualmente la nostra vita sia più vicina allo stato di sonno che non a quello di veglia, praticamente viviamo una vita da addormentati e solo lavorando con grande disciplina su noi stessi potremo raggiungere il necessario livello di consapevolezza indispensabile per la rinascita.
Sono le convenzioni di cui siamo imbottiti che costituiscono la morale soggettiva. Ma una vita vera esige la morale oggettiva, che può venire soltanto dalla coscienza. La coscienza è la stessa dovunque: qui è come a Pietroburgo, come in America, nella Kamčatka o nelle isole Salomone. Oggi sei qui, ma domani puoi essere in America. Se hai una vera coscienza, e se ad essa adegui la tua vita, dovunque tu sia, tutto andrà bene.
La principale causa dell’assopimento è data dalle famigerate convenzioni. È davvero molto difficile rendersi conto di quanto influiscano sulla nostra esistenza e fino a che punto ci limitino, per quanto in questo blog, ben prima di leggere Gurdjieff, è stata mossa contro di esse una guerra senza frontiere. Egli sostiene che se una coscienza ha l’opportunità di svilupparsi liberamente allora di certo sa più di quanto si possa trovare nei libri o di quanto possano insegnare i maestri, e suggerisce inoltre, nei casi in cui la coscienza non è ancora perfettamente formata, per evitare errori clamorosi, di adeguarsi all’insegnamento di non fare agli altri ciò che non si vorrebbe subire su sé stessi.
 Se i sermoni di frate Seze producono immediatamente una forte impressione, alla lunga tale impressione invece scompare e, alla fine, non ne rimane assolutamente nulla. Quanto alla parola di frate Akhel, in un primo momento essa non fa quasi nessuna impressione. Ma, col tempo, l’essenza stessa del suo discorso acquista di giorno in giorno una forma più definita e penetra interamente nel cuore dove rimane per sempre.
Se i sermoni di frate Seze producono immediatamente una forte impressione, alla lunga tale impressione invece scompare e, alla fine, non ne rimane assolutamente nulla. Quanto alla parola di frate Akhel, in un primo momento essa non fa quasi nessuna impressione. Ma, col tempo, l’essenza stessa del suo discorso acquista di giorno in giorno una forma più definita e penetra interamente nel cuore dove rimane per sempre.
Colpiti da questa constatazione, ci mettemmo tutti a cercare perché ciò accadeva, e giungemmo alla conclusione unanime che i sermoni di frate Seze provenivano soltanto dal suo intelletto, e non agivano, di conseguenza, che sul nostro intelletto, mentre quelli di frate Akhel provenivano dal suo essere e agivano sul nostro essere.
Eh sì, caro professore, il sapere e la comprensione sono due cose completamente differenti. Soltanto la comprensione può portare all’essere. Il sapere di per se stesso non ha che una presenza passeggera: un nuovo sapere caccia via il precedente, e, in fin dei conti, non è altro che del nulla versato nel vuoto.
Un concetto molto importante che viene sviluppato è quello della conoscenza. Non è tanto l’accumulare sapere enciclopedico quanto il comprendere che porta all’essere e si può ben capire fino a che punto potesse essere rivoluzionario e sconcertante un tale modo di pensare per l’epoca. Naturalmente Gurdjieff non rifiuta il sapere in sé, ma mostra come esso sia frutto di altri automatismi, di una concatenazione mnemonica e senz’anima. Se però il sapere, come insieme di informazioni apprese, si unisce alle esperienze personali vissute, alla pratica, allora ecco che abbiamo quella forma di conoscenza che arricchisce e permette una visione d’insieme ampia e nitida che agevola il cammino verso di sé e verso il risveglio.
Gurdjieff, per bocca di un anziano intellettuale persiano, non risparmia stoccate mortali alla cultura europea:
Purtroppo l’attuale periodo culturale – che noi chiamiamo civiltà europea, e che così verrà chiamato dalle generazioni future – è intercalare, se così si può dire, nell’evoluzione dell’umanità; in altri termini, è un abisso, un periodo di vuoto nel processo generale di perfezionamento umano, perché, ed è un fatto acquisito, i rappresentanti di questa civiltà sono incapaci di tramandare ai loro discendenti alcunché di valido per lo sviluppo dell’intelligenza, questo motore essenziale di ogni perfezionamento.
Se la letteratura è uno dei principali mezzi per lo sviluppo dell’intelligenza ecco che la civiltà contemporanea distruggendola ha anche impedito l’ulteriore crescita spirituale e intellettuale dell’umanità, creando un punto di stallo, una frattura forse insanabile per un tempo lunghissimo.
Le esigenze della civiltà contemporanea hanno generato un’altra forma molto specifica di letteratura, che viene chiamata giornalismo. Non posso passare sotto silenzio questa nuova forma letteraria, perché, a parte il fatto che non porta assolutamente nulla di buono per lo sviluppo dell’intelligenza, essa è diventata, a mio avviso, il male dei nostri tempi, nel senso che esercita un’influenza funesta sui rapporti umani.
Ma c’è una forma letteraria ancora più subdola e pericolosa che contraddistingue la società moderna, si tratta del giornalismo, un tema quanto mai attuale in questo periodo. Secondo l’anziano il diffondersi del giornalismo è la diretta conseguenza della debolezza e mancanza di volontà da parte degli uomini di oggi. In questo modo si viene a creare una paralisi del pensiero che impedisce al senso critico di analizzare la realtà esterna con lucidità così da prenderne coscienza e in tal guisa recuperare anche la memoria di sé.
Per sfortuna di noi tutti questo genere di letteratura, che invade ogni anno di più la vita quotidiana degli uomini, fa subire alla loro intelligenza, già molto indebolita, un indebolimento ancora peggiore consegnandola inerme a ogni genere di inganni e di errori; essa li mette fuori strada a ogni passo, li distoglie da qualsiasi modo di pensare più o meno fondato e, invece di un giudizio sano, stimola e fissa in loro alcune tendenze indegne quali: incredulità, ribellione, paura, falso pudore, dissimulazione, orgoglio, e così via.
Se vogliamo fare un paragone con il giornalismo dei nostri giorni non possiamo non trovarci d’accordo sul fatto che manca totalmente di obiettività e oltre ad una sempre più evidente pletora di frasi sgrammaticate, scarsa proprietà di linguaggio e un lessico povero e involgarito, non meno importante è il fatto che spesso, nelle pagine di riviste e quotidiani, si impone un pensiero di maggioranza o si è asserviti a quello dei proprietari dei giornali in questione. Tutto questo sopprime il senso critico, il pensiero personale e contribuisce a rendere sempre più semplice potere ingannare e rendere schiava la popolazione.
Tra questi operai del giornalismo e della letteratura contemporanea lo spirito di corpo è molto sviluppato: essi si sostengono a vicenda e si lodano in ogni occasione in modo esagerato. Mi sembra anzi che questa caratteristica sia la causa principale della loro proliferazione, della loro falsa autorità sulla massa, e dell’adulazione incosciente e servile dimostrata dalla folla per quelli che si potrebbero definire, con la coscienza a posto, delle perfette nullità.
Per abbattere i muri, infrangere tutte le maschere che ci appesantiscono, rallentano, rendono deboli, ipocriti, è necessario imparare a trovare la propria anima, che non è un dono, ma è anch’essa qualcosa che si deve guadagnare anche e soprattutto con la sofferenza. Lo smantellamento delle illusioni, di quello che ci si è abituati a credere di essere, lo sforzo di rinunciare all’assopimento, rinunciare al proprio ego imperante, tutto questo richiede uno sforzo enorme e un dolore cosciente.
«Dopo quell’incontro, il mio mondo interiore e il mio mondo esteriore sono completamente cambiati. Nelle concezioni che si sono radicate in me, è avvenuta spontaneamente una revisione di tutti i valori. Prima di questo incontro ero un uomo completamente assorbito dai propri interessi e dai propri piaceri personali, come pure dagli interessi e dai piaceri dei propri figli. Ero sempre rivolto, col pensiero, a cercare di soddisfare il meglio possibile i miei bisogni e i loro. Posso dire che fino a quel momento tutto il mio essere era dominato dall’egoismo e tutte le mie emozioni e manifestazioni provenivano dalla mia vanità. Il mio incontro con padre Giovanni ha fatto giustizia di tutto questo e da allora, a poco a poco, in me è apparso qualcosa che ha portato tutto me stesso alla convinzione assoluta che al di fuori delle agitazioni della vita esiste qualcos’altro che dovrebbe essere lo scopo e l’ideale di ogni uomo più o meno capace di pensare – e che questo altro soltanto può rendere l’uomo veramente felice e offrirgli dei valori reali, invece di quei ‘beni’ illusori che, nella vita comune, gli vengono prodigati sempre e dovunque».
Non so molto di e su Gurdjieff, ma qualunque mortale venga mitizzato, osannato, elevato al rango di semidio, suscita in me innumerevoli perplessità. Anche in presenza di insegnamenti validi e affascinanti, non bisogna mai dimenticare che ci si trova sempre di fronte a delle persone. Perciò se si vuole seguire un certo orientamento va tutto bene, purché non si perda mai il senso critico e non si ponga nessuno su un piano oltre-umano. La tendenza principale dell’uomo è la natura gregaria, molti sentono il bisogno di riunirsi in gruppo, di sentirsi dire cosa fare, cosa è giusto, cosa è sbagliato e soprattutto il fatto di prendere come punto di riferimento qualcuno in particolare da idolatrare (e responsabilizzare) è qualcosa che nella storia dell’umanità si verifica sistematicamente, a volte con effetti devastanti. Se c’è un leader c’è anche un corteo di adoratori sperticati, pronti a servirlo, riverirlo e a sacrificare sé stessi pur di assecondarlo. Se non vogliamo scomodare personaggi storici di cui si parla e si è parlato in ogni epoca, basta pensare all’incessante proliferare di sette e congregazioni varie, in tutte le parti del mondo, dal credo spesso farneticante e malgrado ciò con un folto seguito di adepti di ogni ceto e cultura.